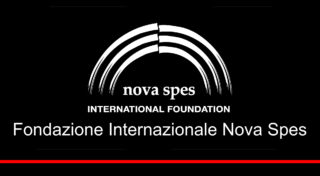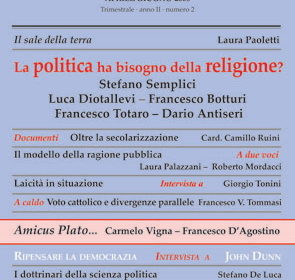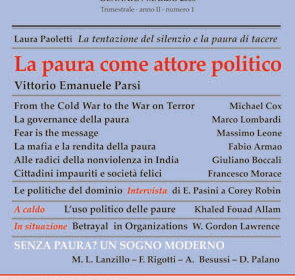Paradoxa, ANNO V – Numero 4 – Ottobre/Dicembre 2011
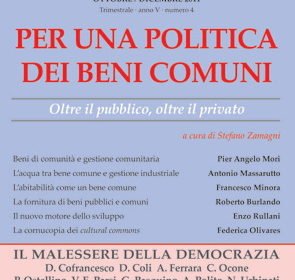
Per una politica dei beni comuni a cura di Stefano Zamagni Il fascicolo 4/2011 di «Paradoxa», curato dall’economista Stefano Zamagni, si occupa di una problematica di estrema rilevanza pratica, che è andata acquistando una crescente centralità nel dibattito pubblico occidentale dell’ultimo trentennio: quella dei beni comuni. I saggi trattano da diverse angolature gli aspetti del problema: acqua, cultural commons, abitabilità; fornitura e gestione dei commons, beni comuni e sviluppo. Tre sono i filoni principali che ne risultano. In primo luogo, il tema della natura peculiare del bene comune, un bene né privato né pubblico. In secondo luogo, la questione del paradigma di razionalità che va adottato nella trattazione dei commons: necessità di superare il modello di rational choice e dell’homo oeconomicus privilegiato dalle scienze sociali e dalla teoria economica. Infine, la questione della gestione dei beni: privata, statalistica o comunitaria? Alcuni interrogativi sollevati dal numero aprono a ulteriori riflessioni e soluzioni: è possibile percorrere una «terza via», alternativa alla proprietà e/o gestione pubblica e privata? È giunto il momento che i cittadini stessi, in forma associativa (cooperative di comunità, cooperative di utenza etc.), assumano il controllo diretto di questi beni? L’applicazione dell’ultima ipotesi esige, secondo il Curatore, una «democrazia più