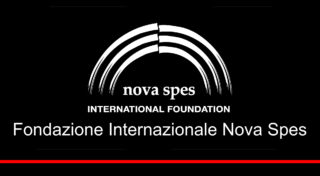Stefano Zamagni – LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’IMPRESA COME FENOMENO EMERGENTE
1. Introduzione Nel presente contributo mi occuperò di tre questioni specifiche, tra loro interrelate anche se concettualmente distinte. La prima concerne la distinzione, affatto chiara sul piano dei principi ma non altrettanto su quello della prassi, tra responsabilità sociale dell’impresa (RSI) e filantropia di impresa. La seconda questione è bene resa dal seguente interrogativo: RSI e competitività sono obiettivi tra loro compatibili; come a dire, l’esercizio della RSI, nelle condizioni storiche attuali, è una pratica economicamente sostenibile? Da ultimo, volgerò l’attenzione ad alcune delle più diffuse critiche che vengono rivolte alla RSI per metterne a nudo l’inconsistenza del loro fondamento teorico. Una considerazione di carattere generale prima di procedere. Non da oggi si dibatte sul punto se l’impresa debba avere obblighi di natura sociale, e non solo legale, nei confronti della società in cui opera. Non è dunque corretto affermare – come talvolta accade di leggere – che il tema della RSI costituisce una res nova dell’attuale fase storica contrassegnata da quel fenomeno di portata veramente epocale che è la globalizzazione. Fin dall’Umanesimo civile – il 15° secolo è il periodo in cui nasce e si diffonde la moderna economia di mercato – si sa che l’impresa sorge come impegno