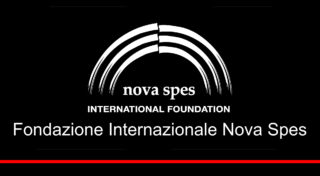Luisella Battaglia e Stefano Semplici – MORTE NOSTRA, MORTE DEGLI ALTRI, ETICA DELLA CURA
(Estratto da Paradoxa 1/2025) Le questioni legate alla ‘entrata’ nella vita e alla ‘uscita’ da essa si sono guadagnate uno spazio importante nell’etica medica fin dalle sue origini e dal giuramento di Ippocrate. Negli ultimi 50 anni il confronto su questi temi è stato al centro della bioetica, ne ha accompagnato la nascita e alimentato la fortuna. A ciò hanno contribuito sia la dinamica di un sempre più vivace pluralismo di prospettive normative e quindi proposte applicative sia il tumultuoso sviluppo delle scienze biomediche e delle tecnologie a esse connesse. Per quanto riguarda più specificamente i problemi che ci si è ormai abituati a definire del fine vita, sono cambiati profondamente, nel volgere di pochi decenni, le circostanze, le modalità, il modo stesso di ‘guardare’ alla morte. Tali trasformazioni hanno prodotto esiti complessi e non sempre convergenti, che coinvolgono la libertà dell’individuo rispetto alle diverse forme del potere – quello politico e delle istituzioni, ma anche quello dei medici –, i valori di autonomia e dignità, il limite nell’uso di trattamenti sempre più efficaci, ma al tempo stesso sempre più invasivi e intrusivi rispetto a un evento inevitabile e al tempo stesso eminentemente ‘personale’, da assumere coscientemente e responsabilmente, nella